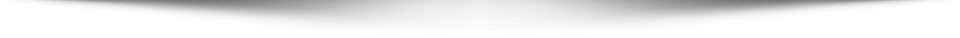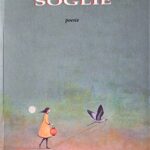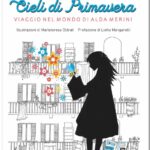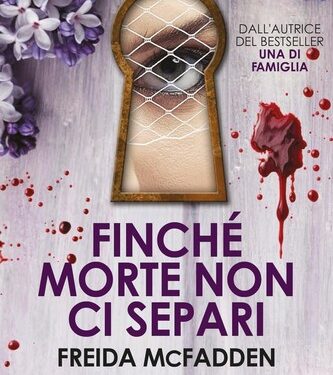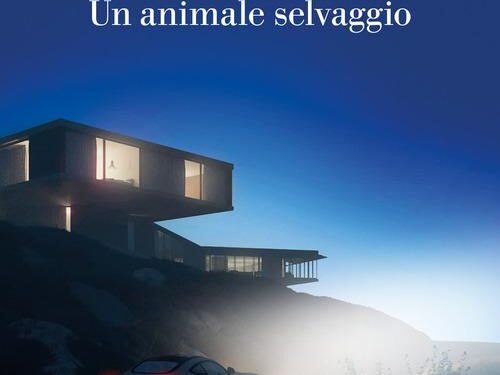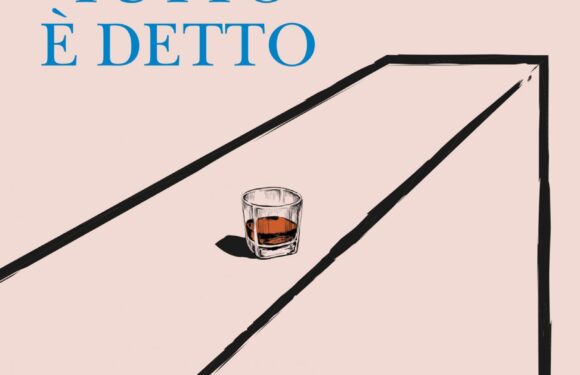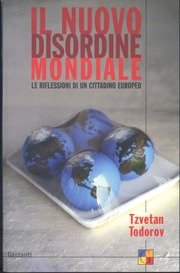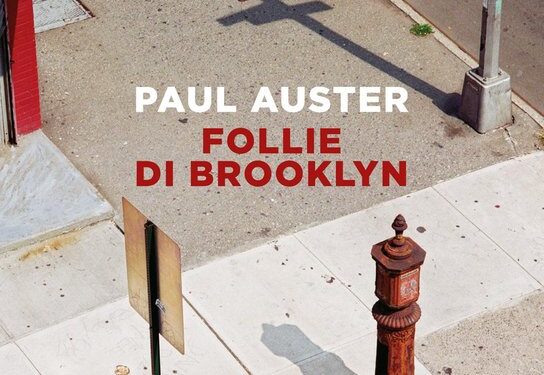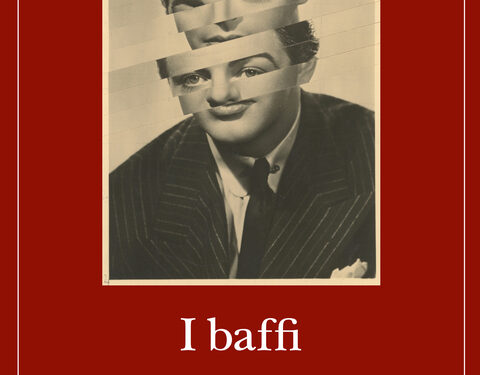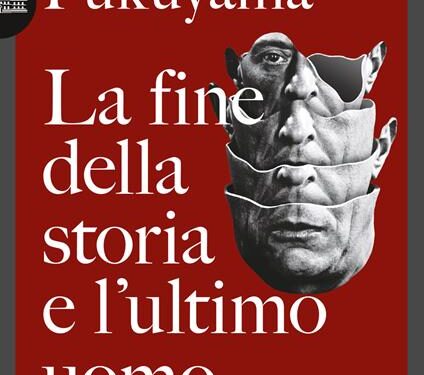Davide Orlandi
Davide Orlandi (Mede, 15/07/1992), sono un insegnante di Filosofia e storia, materie letterarie e linguistiche negli istituti medi e superiori.
Ho cinque lauree e attualmente sono dottorando in Filosofia presso l'Università di Granada.
Dal mese di Maggio 2017 collaboro con il portale di filosofia “Pensiero Filosofico”.
Sono volontario soccorritore e centralinista della Croce Azzurra Robbiese.
Donatore sangue, volontario e consigliere dell'Avis comunale di Robbio.
Volontario dell’associazione robbiese “I Live Panta Rei”, associazione che si batte per gli ultimi e per combattere ogni forma di discriminazione sociale.
Corrispondente per il settimanale d'informazione “Il Corriere Eusebiano”, con sede a Vercelli (VC).
Dal 2022 collaboro con il Giornale letterario.
Membro del comitato di redazione della Rivista di filosofia e scienze umane "Le voci di Sophia".
Ho vinto innumerevoli concorsi letterari nazionali e internazionali, sia a carattere poetico-aforistico che filosofico. Da giugno 2024 sono consigliere comunale di maggioranza della mia città (Robbio Lomellina) e presidente della medesima Biblioteca civica.
Con Aracne ho pubblicato i seguenti libri: Cartesio e Bourdin. Le settime obiezioni (2016); Linguaggio e forme di vita. Saggio su Ludwig Wittgenstein (2017); Diego Marconi e la sua competenza lessicale. Un'analisi critica (2019).
Interpretazioni di interpretazioni. Indagine sul prospettivismo nietzschiano, Youcanprint Editore, 2020; Come guarire dai social network attraverso due romanzi, Youcanprint Editore, 2021; Quel pazzo di Nietzsche. Come leggere la nostra vita e quelle altrui, AbelPaper, 2022; L'occasione del cambiamento, Youcanprint Editore, 2022; Frammenti di vita. Come un grido nella notte, Youcanprint Editore, 2023; Il Turismo al tempo del Covid-19, Youcanprint Editore, 2024.
Ho collaborato con varie personalità di spicco del panorama culturale italiano e straniero come Mogol, Alfredo Rapetti Mogol (Cheope), Vittorio Sgarbi, Francesco Gazzè, Alessandro Quasimodo, Cosimo Damiano Damato, Hafez Haidar, Francesco Baccini, Tomaso Kemeny, Dato Magradze, Nunu Geladze, Reddad Cherrati, Franco Arminio e molti altri.
Nel 2021 sono stato nominato “Uomo Illuminato” dagli Stati Generali delle Donne. Nel 2024 mi sono aggiudicato il Premio Nazionale di Filosofia, con il volume: Quel pazzo di Nietzsche. Come leggere la nostra vita e quelle altrui, AbelPaper, 2022.