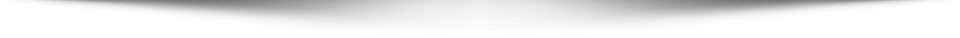Il Canto XXVI dell’Inferno: tra mondo classico ed epoca contemporanea
Il personaggio di Ulisse viene collocato, da Dante, nel XXVI Canto dell’Inferno.
Nella misura in cui l’Ulisse dantesco presenta molti caratteri comuni con l’Ulisse omerico, ritengo adeguato, in sede introduttiva, passare in rassegna questa tradizione.
Sin dall’Iliade, ne viene elogiata l’“areté” (“virtù”) greca: la sua straordinaria saggezza ne fa un insuperabile stratega, sul piano delle decisioni belliche. Esattamente ad Ulisse, giunge l’ispirazione per l’inganno del “cavallo di Troia”: l’eroe spalanca agli Achei (i Greci) la vittoria della guerra contro Troia.
Nell’Odissea, abbiamo a che fare con Ulisse “homo viator”, tendente a percorrere il mondo e spinto dal desiderio di sapere. Ricordiamo che il lasso di tempo che intercorre tra la partenza ed il ritorno nell’amata Itaca è di ben 20 anni. La sua virtù lo conduce al successo, dopo gli incontri con la maga Circe, il ciclope Polifemo e le Sirene: riesce sempre a fuggire, grazie a svariate strategie.
Forte del patrimonio ereditato dai poemi omerici, Dante riserva ad Ulisse una punizione particolare, per via dell’irrefrenabie istinto di sapere: lo posiziona nell’ VIII “Bolgia” dell’VIII “Cerchio” (“consigleri fraudolenti”). Non appena è pervenuto ai limiti del mondo geograficamente conosciuto, Ulisse spinge i compagni verso il “mondo sanza gente”; ossia, una reltà mai esplorata (“priva di popolazione”), idealmente un “mondo altro”. L’eroe brama la conoscenza di ciò che non può essere, per natura, abbracciato dallo sguardo dell’uomo, poiché si colloca oltre il limite. “Geografia” (come luoghi fisici esplorati) e “gnoseologia” (il sapere) si incontrano: l’esperienza concreta è conoscenza a pieno titolo.
Come avviene durante l’incontro con le Sirene, si tratta dell’impossibile, che non può essere esperito.
La lettura di Massimo Donà in “Abitare la soglia” ci permette di comprendere come tale episodio corrisponda perfettamente all’atteggiamento dell’Ulisse dantesco. Le Sirene promettono ad Ulisse l’irrealizzabile infinito, oltre il quale “tutto si può sapere”. La ragione viene posta di fronte all’impossibile e, di per sé, cederebbe ad una siffatta situazione illusoria. Infatti, il sapere assoluto (dal latino “ab-solvere”, “rendere sciolto”), non può essere veritiero, in quanto disancorato dalla realtà; non se ne può fare esperienza.
Alla stessa maniera, nelle celebri terzine in cui Ulisse invita i suoi compagni a seguire “virtute e canoscenza”, egli pretende da costoro l’esatto opposto del suo comportamento, proteso verso l’inattingibile assoluto.
Secondo un’esegesi parimenti accreditata, questi due termini (virtù e conoscenza), che Dante mutua dalla tradizione della filosofia di Epicuro (341 – 270 a.C.), verrebbero attribuiti in modo improprio, da Dante, ad Ulisse. Quest’ultimo, sul piano cronologico, precederebbe (per quanto sia un personaggio della mitologia) gli epicurei e non potrebbe, dunque, conoscerne la filosofia.
Da una parte, Dante avrebbe commesso un errore ermeneutico (legato alla sua lettura di Ulisse); d’altra parte, l’atteggiamento di Ulisse non darebbe prova di incarnare quella stessa virtù e quella stessa conoscenza, di cui ritiene di essere depositario. Infatti, secondo gli epicurei, la vera felicità spetta a colui che riesce saggiamente a perseguirli.
Ulisse rimane (tanto in Omero, quanto in Dante), in preda al suo istinto “schizofrenico” (provoca una dissociazione, tra le parole pronunciate e la sua effettiva condotta, in senso morale). Precisamente per queste ragioni, Dante lo colloca all’Inferno.
La figura di Ulisse, ripresa nel XIX e XX Secolo -in modo tutt’altro che anacronistico-, può essere riconducibile all’artista romantico e contemporaneo. Entrambi vivono un profondo tormento, un irrefrenabile senso di insoddisfazione. Perfezionismo ossessivo; ma anche, disagio esistenziale. Il perfezionismo ossessivo è la tendenza a concepire componimenti artistici “dettati” da una particolare ricercatezza e raffinatezza, talvolta eccessive, in quanto coinvolgono l’autore in maniera totale, rivelandosi corrosivi per il suo stato emotivo. Il disagio esistenziale consiste nello stare al mondo avvertendo una frattura con la realtà, da cui l’artista ribelle, spesso visionario, si distacca, per infrangerne i canoni e creare in maniera del tutto libera e innovativa.
Giungiamo, infine, alla letteratura del Novecento, con James Joyce (1882-1941). L’autore irlandese è passato alla storia con l’omonimo romanzo, “Ulisse”, dove i personaggi principali (Leopold e Molly Bloom, Stephen Dedalus) ricalcano quelli omerici. L’itinerario conoscitivo ereditato dalla tradizione omerica è pressappoco il medesimo. Ciononostante, il paradigma dantesco viene radicalmente sovvertito: nessun’idea di “ordine” a carattere metafisico o morale. Prevale la forma del monologo in cui, attraverso il cosiddetto “stream of consciousness” (“flusso di coscienza”), si esprime una modalità di comunicare innovativa e rivoluzionaria, in quanto basata su libere associazioni -a carattere non solo, ma anche psicanalitico-, secondo uno stile disarticolato.
Per citare i filosofi Vincenzo Vitiello e Italo Valent, in tal caso, “la crisi del linguaggio” si rovescia in un “linguaggio della crisi”. Se la facoltà determinativa e razionale del linguaggio è posta davanti al suo scacco, proprio questo diventa il momento in cui tale “crisi” trova, invece, la massima espressione: la frammentarietà dell’io, tema spesso presente nel XX Secolo.
Risulta evidente come, da Omero a Joyce (passando attraverso Dante), Ulisse continui a “peregrinare”, seppur sulla base di espedienti narrativi e lessicali che variano, a seconda delle epoche storiche in cui sono collocati.
Tutte queste interpretazioni si rivelano, pur sempre e comunque, portatrici di un senso profondo, che affonda le radici nella “Grecità”.
Stefano Chiesa